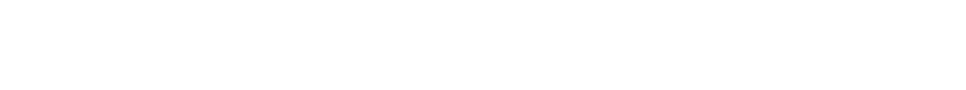Sono tre le sezioni del Museo etno archeologico dedicato alla cultura africana, ospitato nella dependance di Villa Toeplitz: Il Deserto del Sahara “storico”, il Deserto del Sahara preistorico e la savana africana.
La prima parte del percorso espositivo è caratterizzato dalla ricostruzione di un grande accampamento Tuareg. Oltre alla tenda, composta da decine di pelli di capra, dipinte di ocra rossa e sapientemente cucite dalle donne, sono presenti tutti gli oggetti e gli utensili della vita quotidiana di questa popolazione: variopinte sacche per i viveri e per gli indumenti, armi, semplici giacigli, oggetti di cucina, indumenti, macine, ecc. La tenda è circondata da una stuoia che funge da parete realizzata da due donne con il sapiente lavoro di un anno.
Nella seconda sala del museo si trova la ricostruzione di una carovana Tuareg probabilmente smarritasi e perita di sete, che evidenzia i rischi che si corrono a vivere in un ambiente ostile come il deserto. Oggi, come nel passato, i pericoli che deve affrontare chi viaggia nel deserto sono sempre gli stessi: perdere la direzione, essere sorpreso da una tempesta di sabbia, trovare un pozzo insabbiato.
Nell’antichità molte carovane solcavano il deserto alla ricerca di pietre preziose e minerali, in particolare l’oro. Questo è il tema trattato nella successiva sala del museo. Facendo un salto nel passato vengono mostrate le tecniche di estrazione dell’oro e gli strumenti utilizzati a questo scopo nel mondo antico “classico”.
Le miniere aurifere del deserto nubiano, soprattutto sudanese, per millenni furono le principali, se non le uniche, produttrici di questo prezioso metallo. Quasi certamente a partire dal IV millennio prima di Cristo fino al XIII secolo della nostra era, le vene di quarzo aurifero vennero continuamente ed intensivamente sfruttate, soprattutto dagli egizi del periodo faraonico che da queste zone ottennero grandi quantitativi del prezioso metallo.
Nella sala successiva, andando indietro ulteriormente nel passato fino a giungere al paleolitico, si possono ammirare i calchi, riprodotti con una speciale resina, dei graffiti dello uadi Bergiug e del sistema dei suoi affluenti, in una località posta a sud ovest della Libia, nelle vicinanze del Tchad, a sud della regione del Fezzan. Nel passato la zona era un centro importantissimo di vita spirituale e il luogo di contatto tra le culture del bacino mediterraneo e delle regioni subequatoriali. Le ricerche condotte sui graffiti da studiosi di varie discipline hanno contribuito a fornirci informazioni sul sistema habitat-società-economia degli uomini che hanno realizzato queste antiche opere d’arte.
Passando alla savana è possibile ammirare le acconciature, i colori, gli ornamenti e la pittura del corpo dei Nilo Camiti, popolazioni che vivono nell’Africa Orientale tra le quali le più note sono i Samburu, i Pokot e i Maasai.
Per mostrarci la preziosità e l’accuratezza del lavoro svolto da acconciatori e decoratori, i fratelli Castiglioni e la loro équipe hanno messo a disposizione degli indigeni più esperti delle parrucche con capelli dalle caratteristiche molto simili a quelli della tribù stessa, invitandoli a riprodurre le varie acconciature. Lavorate con la stessa meticolosità degli originali, le parrucche sono appoggiate su busti di terracotta modellati appositamente da uno scultore in base all’antropologia fisica, tecnica che ha consentito la riproduzione dei caratteri somatici tipici dell’etnia.
Nell’ultima stanza sono esposti, in tre vetrine, gli oggetti di uso quotidiano, i vestiti, gli ornamenti, i gioielli e le armi dei Nilo camiti.
Per informazioni: 03321694229 – info@museocastiglioni.it – www.museocastiglioni.it