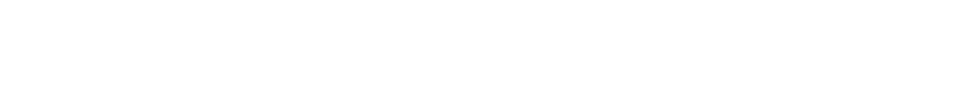“Quando ho pensato ad un percorso di poesia per Penasca, dopo aver portato lo scorso anno i versi di Antonia Pozzi, ho voluto ripercorrere la storia del borgo, quel lavoro in fabbrica che da questi luoghi si nutriva di manodopera. E pensando alla poesia nel lavoro, non potevo non farmi accompagnare dall’operaio-poeta di Rasa in Varese”. Antonella Visconti si presenta sotto le luci dell’ultimo sole nel Santuario del Borgo Penasca, dove si è celebrata la due giorni di “Un borgo da riscoprire”. Preannuncia il suo percorso di scoperta, al cospetto delle organizzatrici che hanno voluto l’incontro, Luisa Oprandi e Patrizia Bonacina degli Amici di San Fermo, di una sottoforma espressiva della poesia che si genera sul luogo di lavoro, che si riferisce ad esso, che lo rigenera. Poi si affida a Sereni per inquadrare gli anni cinquanta e gli intellettuali che hanno guardato la fabbrica dal di fuori. E soprattutto con strumenti culturali di analisi. Poi coinvolge anche il Manzoni per dimostrare quanto, comunque, sia necessaria l’attenzione anche del mondo accademico verso questa “manifestazione in versi”, priva di un io narrativo, ma ricca di un io collettivo.

In un reading continuo, compito, e quasi commosso, Visconti ha condotto il pubblico in un viaggio scandito dal vero verso della letteratura in fabbrica.  Per poi svelare il suo incontro con le raccolte di poesia dalla fabbrica e lasciarsi attraversare da quella di Ferruccio Brugnaro, di cui ha addirittura performato i versi d’amore dedicati alla sua Maria.
Per poi svelare il suo incontro con le raccolte di poesia dalla fabbrica e lasciarsi attraversare da quella di Ferruccio Brugnaro, di cui ha addirittura performato i versi d’amore dedicati alla sua Maria.
L’operaio di Porto Marghera conquista la relatrice che coinvolge delineando uno dei
protagonisti delle lotte per i diritti dei lavoratori, dopo essere entrato a far parte del
Consiglio di Fabbrica Montefibre-Montedison.
I versi di Brugnaro, tradotti in tutto il mondo, si ritmano sulla morte collettiva: in prima persona visse la tragedia legata alle manifestazioni tumorali collettive, determinati dalle sostanze a cui erano esposti i lavoratori. Inconscientemente ed inconsciamente. La sua attività di scrittore, infatti, inizia nel 1965, quando distribuisce ciclostilati di poesia, racconti e pensieri presso i quartieri e le scuole frequentati dai lavoratori in lotta.  Proprio come l’operaio-stupidino in Rasa di Varese, quel Sandro Sardella che ha in comune con Brugnaro anche la partecipazione al San Francisco International Poetry Festival, oltre alla condivisione delle scrivanie di “abiti-lavoro” – Quaderni di scrittura operaia, la rivista che ha tracciato la storia della letteratura subalterna italiana dalla fine degli anni ’70 ai primi anni ’90, ma che ancora spesso gli studi sul genere omettono.
Proprio come l’operaio-stupidino in Rasa di Varese, quel Sandro Sardella che ha in comune con Brugnaro anche la partecipazione al San Francisco International Poetry Festival, oltre alla condivisione delle scrivanie di “abiti-lavoro” – Quaderni di scrittura operaia, la rivista che ha tracciato la storia della letteratura subalterna italiana dalla fine degli anni ’70 ai primi anni ’90, ma che ancora spesso gli studi sul genere omettono. 
E su questo trait-d’union l’operaio-poeta (ormai pensionato-poeta) si lascia andare al ricordo di un tempo passato con Brugnaro e con tutta una redazione che fermeva e fremeva intorno ai temi più scottanti e tangibili. Anche lui con le sue “Carte ciclostinate” che parlavano dei padroni, delle malattie, dei diritti con ironia tagliente. L’unica forma che è riuscita a portare fino ad oggi questa parola testimone contro i proclami partitici che han consegnato la categoria operaia nelle mani del populismo di nuovi partiti, per nulla lavoratori. Sandro Sardella calamita nel suo racconto e compie una scelta ammirevole: non legge i propri versi, ma offre al pubblico quelli di un’altra figura chiave della letteratura subalterna: Luigi Di Ruscio.
Morto a Oslo nel 2011, dove era emigrato nel 1957 per lavorare in una fabbrica metallurgica, Di Ruscio ha visto riconosciuta la sua opera solo dopo la scomparsa addirittura dall’accademia. Ma la sua prima pubblicazione “Non possiamo vederci morire” del 1953 era prefatta da Franco Fortini per i tipi di Arturo Schwarz.  Nel marzo 2014 anche Feltrinelli gli ha dedicato un volume a cura di Cortellessa e Ferracuti, ma concentrato sulla prosa, più che sulla poesia operaia.
Nel marzo 2014 anche Feltrinelli gli ha dedicato un volume a cura di Cortellessa e Ferracuti, ma concentrato sulla prosa, più che sulla poesia operaia.  Sardella ha regalato, invece, i suoi versi pungenti della cruda realtà, ma di una forza che varca ogni confine. Forse perché il Santuario di Borgo Penasca ha ri-accolto i suoi lavoratori dal verso vero.
Sardella ha regalato, invece, i suoi versi pungenti della cruda realtà, ma di una forza che varca ogni confine. Forse perché il Santuario di Borgo Penasca ha ri-accolto i suoi lavoratori dal verso vero.